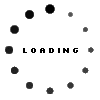Questo mese ricordiamo un anniversario di morte molto importante: sono 380 anni dalla scomparsa di Pieter Paul Rubens.
Uno dei più importanti pittori fiamminghi del XVII secolo e figura centrale dell’arte barocca del Nord Europa, Rubens nasce nella città di Siegen, in Westfalia, nel 1577.
Nell’anno 1600 Rubens fa un viaggio in Italia e vi rimane per otto anni, assimilando le lezioni di grandi artisti tra cui Caravaggio, Michelangelo, Raffaello e Tiziano.
Rubens torna nelle Fiandre, a Anversa, nel 1609, divenendo pittore di corte dei viceré spagnoli Alberto e Isabella, reggenti dei Paesi Bassi.
La pittura barocca di Rubens è grandiosa e trionfale, giocata su forti contrasti chiaroscurali. Le scene sono affollate, dinamiche e impetuose, i colori intensi e brillanti, i corpi massicci, così da conferire all’intera composizione un senso di teatralità.
Rifacciamoci gli occhi con i meravigliosi capolavori di Pieter Paul Rubens.
Trittico della Deposizione dalla Croce

In questo trittico, conservato presso la Cattedrale di Nostra Signora di Anversa, Rubens racconta il dramma della deposizione dalla croce di Cristo. Giovanni sostiene il corpo inerte di Gesù, calato da Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea. A sinistra, vediamo la Vergine disperata che sfiora il gomito del figlio e la Maddalena, inginocchiata, che sostiene i piedi di Cristo.
Daniele nella fossa dei leoni

Il soggetto è preso dal libro di Daniele, testo contenuto nell’Antico testamento. Il re di Babilonia, Dario, pose a comando dei suoi uomini Daniele. Essi rifiutarono l’autorità di Daniele e, sapendo che egli pregava Dio, si recarono dal re e gli chiesero di emanare una nuova legge: il popolo non poteva pregare Dio; coloro che avessero disobbedito sarebbero stati gettati nella fossa dei leoni. Il re fu costretto a gettare Daniele in pasto alle belve ma, la mattina seguente, quando andò a controllare la fossa, Daniele era ancora vivo. Egli disse che Dio aveva chiuso la bocca ai leoni.
Sansone e Dalila

L’opera viene dipinta poco dopo il ritorno di Rubens ad Anversa, di rientro dall’Italia. Ispirato a un episodio biblico, la tela raffigura Sansone addormentato sulle gambe di Dalila, mentre un filisteo gli taglia i capelli, fonte della sua forza prodigiosa. Il chiarore della candela e del braciere illuminano la scena e conferiscono un senso di teatralità. I colori, intensi e pastosi, sono stesi in pennellate energiche. Evidenti sono i rimandi a Michelangelo, come si vede nella muscolatura di Sansone, e di Caravaggio, se si osserva il braccio abbandonato di Sansone che ricorda quello della “Deposizione”.
Autoritratto con la moglie Isabella Brant

L’opera fu probabilmente eseguita da Rubens poco dopo il 3 ottobre 1609, data del suo matrimonio con Isabella Brant. Il pittore rinnova la tradizione nordica del doppio ritratto nuziale a figura intera (si pensi al “Ritratto dei coniugi Arnolfini” di Jan van Eyck). La coppia, mano nella mano, è seduta in giardino, sotto un augurale caprifoglio fiorito. I coniugi indossano abiti preziosi e alla moda, i cui tessuti, pizzi e gioielli sono realizzati minuziosamente. Il ruolo dei due personaggi è definito dalle loro posizioni: Isabella è seduta sul prato mentre Rubens è posto in una posizione più elevata e tiene la mano sinistra sull’elsa di una spada.
Ratto delle Leucippidi

Esistono due interpretazioni di questo quadro: il primo raffigurerebbe il mito del rapimento delle Leucippidi, figlie del re di Tessaglia Leucippo, a opera dei Dioscuri; la seconda, invece, scorge in questa tela il mito del Ratto delle Sabine. La scena presenta un ritmo vorticoso, ma non trasmette violenza o paura. Le giovani, infatti, non sembrano opporre grande resistenza e gli sguardi dei ragazzi non appaiono violenti o feroci, bensì ricordano quelli due innamorati. L’atmosfera è velata di erotismo, come dimostra la presenza dell’amorino sulla sinistra che, con un sorriso malizioso, tiene le redini dei cavalli.
Il Giardino dell’amore

Il tema del giardino in cui si celebra l’amore coniugale fu riprodotto più volte dai pittori francesi del Settecento. Nel giardino seicentesco si trova un tempietto classico e una statua della dea Giunone, all’interno di una fontana, a simboleggiare l’unione coniugale. Alcuni storici hanno supposto che le figure femminili siano tutti somiglianti alla seconda moglie di Rubens, Helena Fourment. I volti, le espressioni, le posizioni e le vesti creano un’atmosfera leziosa e voluttuosa. La luce dorata del sole trasmette grande vitalità al dipinto e, allo stesso tempo, il modo in cui sfiora i personaggi, l’ambiente e i ruderi infonde un’atmosfera sognante.
Ritratto della marchesa Brigida Spinola Doria

Il quadro fu commissionato dal marchese Giacomo Massimiliano Doria, figlio del Doge di Genova Agostino Doria. L’impronta filo-spagnola impressa alla politica della Repubblica genovese influenzò anche il costume della società. L’abito indossato dalla donna ritratta da Rubens, la marchesa Brigida Spinola Doria, moglie di Giacomo Massimiliano, presenta per l’appunto la tipica foggia spagnola. Il ricchissimo abito in satin bianco è ricamato in oro e decorato da file di bottoni dorati che dal bustino scendono lungo tutta la gonna. Il corpetto è molto aderente e al di sopra delle maniche si apre una sontuosa gorgiera arricciata. L’acconciatura è decorata da preziose spille ornate di perle, presenti anche ai lobi delle orecchie della marchesa.